“Ma quando lo scrivi un libro? Perché non lo scrivi? Devi scrivere un libro!
Tante volte Ignazio Vanadia si è sentito dire queste parole dagli amici realmente incontrati o virtualmente raggiunti che erano la prova che la sua scrittura riusciva a incantare. Ma tra il compiaciuto e ironico sorridere alle lusinghe ricevute e mettersi all’opera per trasformare in libro i suoi fogli volanti c’era la fatica di un’impresa che, come lui stesso dice, “gli pareva come la cima di una montagna osservata, temuta e desiderata dalla valle prima della scalata.” Non è difficile immaginare i tentennamenti, i ripensamenti e i pentimenti che lo avranno assalito dopo la decisione di scrivere il suo libro autobiografico che sapesse “raccontare di quel paradiso che c’era al di qua di quel cancello della sua infanzia e poi di ciò che accadde a lui e ai suoi compagni al di là, quando sarebbero diventati adulti”, ma, una volta iniziata l’opera, Ignazio che è intanto diventato il personaggio Pino Fundrisi, non si ferma più e, dopo aver affidato l’incipit alla voce di un narratore esterno, continua a raccontare anzi a raccontarsi anche se sceglie di farlo senza una vera trama.
Come espediente narrativo, per scongiurare la monotonia di un’unica voce narrante e per riuscire a dare un doppio registro descrittivo, uno più interiore e atemporale, e l’altro più esteriore e storico, immagina di inviare il suo scritto a un unico destinatario: Antonio Presti, amico sin dall’infanzia con cui era stato sempre possibile “ afferrare al volo ogni minimo pensiero che passava per la … testa, prima ancora che si trasformasse in parole o azione”, ma che ha lasciato il paese d’origine e vive in una città del Nord.
Tra le pagine inviate all’amico, allora, ritroviamo il ritratto interiore di Pino in cui si nasconde o forse è il caso di dire si svela l’autore che ci confida la sua continua ricerca del senso della vita, possibile, però, solo attraverso una “metafisica delle cose inutili” che come “ una specie di lente d’ingrandimento … permette di distinguere ciò che normalmente non è considerato: gioie ritagliate a forma di stelle per ornare i Natali, … sogni difficili anche solo da accarezzare, … minimi accadimenti che hanno l’aria di essere stati finemente programmati da qualcuno, … certi profumi che non senti da quando eri bambino, certe assenze che sembrano presenze “. Animato da questo desiderio di ricerca, come “un malinconico cultore del bello e del buono“ con il suo esistenziale senso di colpa per “la diseguale distribuzione del benessere”… lo vediamo vagare “per il paese antico a cercare storie nascoste in attesa di essere scoperte o rivelate.” Nel raccontarsi le sue parole si fanno docili al vento che senza un regolare ordine, proprio come un aquilone, le spinge ora tra persone e luoghi alla memoria del passato, ora sui passi del cammino tra vicoli e strade del quotidiano per guidarle infine nel sogno di un futuro che superi i limiti temporali per farsi infinito.
Ma l’infinito si conquista partendo dai luoghi della memoria e, infatti, il protagonista, ripercorre la strada che lo porta nel punto più alto del paese ai piedi della deserta chiesetta di Santa Croce dove in una sosta dettata dalla sua “ fede anemica” tenta una preghiera che possa “ mantenere costante il sentimento di Dio”, volgendo il suo sguardo non al cielo ma giù verso il centro abitato, familiare groviglio di strade e case.
Per arrivare alla pienezza d’infinito, infatti, dovrà partire dal basso e si incammina verso “ il sud dell’esistenza umana … dove il poco basta ma di meno si muore”. In questo suo “camminare creativo”, mentre ritrova gli antichi ricordi dell’infanzia e sente la nuova capacità di “ascoltare … l’anima di questo luogo che parla”, ripete nel silenzio della mente il pascoliano verso “C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico” che non è solo una reminiscenza scolastica, ma la dichiarazione di una filiazione ufficiale a cui rimanderebbe il titolo del libro, “Come il volo irregolare di un aquilone”, visto che il verso è tratto dalla poesia “L’aquilone”. Oltre alla voce di Pascoli, però, si sentono anche altri echi letterari e allora in questa liturgia delle piccole cose il rumore di stoviglie che proviene da una casa del “paese antico” e che risuona come l’eco di una semplice “serenità giornaliera” rimanda immediatamente alla serenità rimpianta da Gozzano che proveniva dalla cucina della Signorina Felicita“ tra le stoviglie a vividi colori … e quegli odori … tanto consolatori di basilico, d’aglio, di cedrina…“. Questa realtà semplice ed essenziale diventa per il protagonista-autore “via d’accesso al mistero” che può essere colto solo nella dimensione del silenzio quello che “riempie l’anima … approdo verso cui può spingere una benevola corrente” che ci fa subito pensare a quei “sovrumani silenzi” di leopardiana memoria e dove in una luce che il sole d’aprile rende tersa e cristallina si perdono gli echi del passato.
Dalle vette dell’infinito le parole sanno anche scendere più in basso, riuscendo a creare situazioni comiche e a essere umoristiche ironiche e autoironiche come quando, immagina di guardarsi allo specchio e, come il pirandelliano Vitangelo Moscarda, non vede più la sua originaria faccia, trovando “al suo posto una scritta: Faccia Persa”. Sanno essere taglienti quando descrivono il nuovo tipo umano che la società contemporanea ha mitizzato e che così appare: “Aggressivo, maleducato, senza scrupoli, costui della violazione della norma ha fatto lo strumento per fare i propri comodi e per procacciarsi privilegi e poteri“. Riescono a essere amaramente pungenti quando l’autore deve ammettere che le parole leali e oneste sono state sostituite da “chi le spara grosse” con altre appena gracchiate che sappiano incantare e portino alla “conquista del consenso”, anche se, ci tiene a precisare, non è operazione facile perché impone di “studiare molto, fare lunghi tirocini con esami su un elenco interminabile di discorsi, uno per ogni circostanza” da pronunziare rigorosamente a “labiali strette”. Sembra di risentire gli sferzanti versi che Molière mette in bocca ad Alceste, il suo teatrale misantropo, quando così dice: ”Niente detesto più dello sdilinquimento/ di tutti questi gran maghi del complimento,/ squisiti prestatori di baci e di carole,/ dicitori finissimi d’inutili parole … / Mi prende l’umor tetro, mi cruccio, m’addoloro/ a veder come vivono gli uomini tra loro.”
Una sensazione non diversa è quella che prova il nostro protagonista quando vede vivere i suoi compaesani nella banalità della vita quotidiana in cui “ogni giorno è come un film già visto, uno stanco ripetersi di abitudini e rituali” per cui “si entra e si esce dalle proprie case, si sale e si scende o si sosta lungo il corso per lamentarsi di qualcosa o ingiuriare qualcuno“.
Questo smarrimento trova la sua massima rappresentazione nel ferragosto, torrido momento di comandata festa paesana, in cui del sole che con la sua luce rendeva terso il cielo dei silenziosi luoghi della memoria adesso resta solo la “calda brodaglia degli abbracci” che spinge Pino a voler scappare lontano dal paese.
La scontrosità quasi selvatica di Pino che traspare tra le pagine del libro non turba Antonio che sa bene che quella dell’amico non è né avversione al suo paese, visto che ”Pino rimase tra i compaesani a condividere con loro le pene di quella terra disgraziata” e non è neanche una sorta di misantropia universale, ma solo profonda delusione nel vedere che gli uomini hanno perso il senso della vita e continuano a tirare avanti senza più chiedersi chi siano e perché ci siano. In questo idealismo quasi romantico Antonio ritrova l’amico di una volta che era sempre pronto a ricordare a lui e agli altri compagni “i drammi della condizione umana e il dovere di un impegno serio verso gli altri” e allora da questo momento inizia a ripercorrere e a raccontare il passato dell’impegno politico e della loro amicizia dandoci di Pino e quindi dell’autore un ritratto più esteriore e storico. Nel “percorso della memoria” riappaiono gli anni Settanta, anni della giovinezza in cui era possibile passare dalla serietà delle riunioni in sezione, a cui si doveva partecipare “come fosse un tributo all’umanità dolente”, alle risate goliardiche e fragorose in cui “annacquare” le impegnate discussioni ideologiche. Sembra di vederli giovani e infervorati del loro entusiasmo, camminare per il corso indossando montgomery con gli alamari che stringevano un’appartenenza ideologica mentre le note di “Io vagabondo” dei Nomadi facevano da sottofondo musicale. Poi come dice Antonio, “il vento cambiò … e venne il tempo di fare cose diverse”. Adesso leggendo le pagine dell’amico non riesce a spiegarsi come sia stato possibile che proprio lui paladino“ dell’impegno per stare in questa società” adesso viva nel disimpegno politico al punto che il passato comunista sia solo un fantasma e che abbia anche scelto di “tagliarsi fuori da ogni dinamica sociale”. La domanda di Antonio, che altro non è che la voce con cui l’autore fa un bilancio della sua vita, trova una risposta proprio nel ritratto di Pino che in questa scelta di doppia voce narrativa l’autore gli affida. “Una mattina, alla soglia della vecchiaia, si accorge di essere ancora vivo e considera che, tutto sommato, questa è la cosa più importante di cui prendere atto e sentirsi felici”. La consapevolezza di una verità esistenziale supera quella dell’ideologia politica e la felicità degli affetti è quella che dà il senso della vita. La si ritrova nel ricordo dei figli piccoli “quando se li portava all’avventura…e…li abituava insomma alla pratica dell’ottimismo” e in una foto che ritrae la moglie Anna che lo guarda e con la forza del suo amore gli permette di guardare lontano, perdendosi nel “silenzio blu” del cielo.
Allora, mentre respira quella pace che sa di infinito che spesso dimentichiamo ma di cui abbiamo sempre nostalgia, ci ricorda che “chi sa ancora aspettare il vento non muore mai veramente”.
È l’augurio più bello che possiamo ricevere.
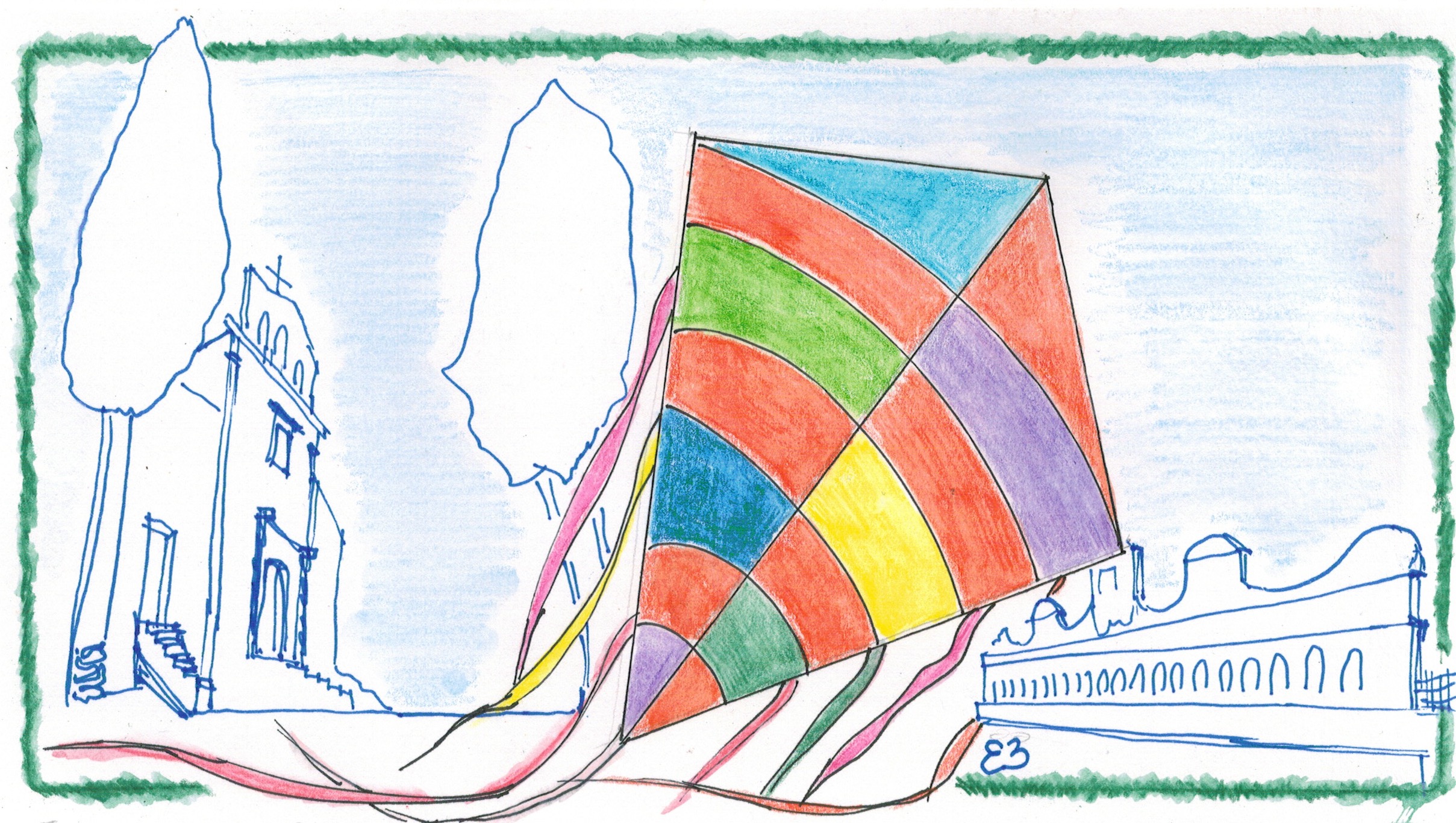

Lascia un commento